
This Heat – self titled (Piano, 1979)Sui cambiamenti climatici si è letto un po’ di tutto. È colpa dell’uomo, della natura, di questo e quell’altro. Ciò che rimane inconfutabile è che fa caldo oggi, come allora.
Correva l’anno 1976 e il Regno Unito assistette a un’ondata di calore davvero anomala. Le soluzioni a quel tempo erano poche. “Perché non chiuderci in una ex cella frigorifera?”, pensarono a un tratto Charles Bullen, Charles Hayward e Gareth Williams, alla ricerca di un po’ di sollievo. In men che non si dica trovarono così il loro nuovo studio di registrazione. Due album e un EP per una band è poco, commercialmente parlando, ma è tutto invece se ci interessa l’altra faccia della medaglia, quella artistica e sperimentale. Se dovessimo dare retta all’anagrafe del trio suddetto, ci perderemmo ancora nelle lungaggini intorno la new wave. La musica di cui parliamo oggi è fatta di piccole istantanee, messe insieme tramite un processo creativo che tende la mano alla scuola di Canterbury, alle influenze dub e all’industriale.
Avete presente il metodo “cut-up”? Basta semplicemente tagliare a pezzi un testo scritto, per poi rimetterlo in piedi in una nuova forma. Pare l’abbiano inventato i dadaisti, ma è una tecnica divenuta celebre con lo scrittore William S. Burroughs. È facile immaginare come la sua applicazione possa riguardare qualsiasi contesto.
Il nostro découpé inizia e termina con “Testcard”, una composizione dal sentore IBM, che da un lato riflette un breve spluttering elettronico (rumore bianco), dall’altro imita lo strepito interno dei primi PC.
A seguire, “Horizontal Hold” ci riporta a un mondo dimenticato, quello dei televisori a tubo catodico, dove ogni cosa andava regolata manualmente. In effetti la traccia non fa che imitare quello stress continuo nel calibrare e regolare, in una ipotetica lotta per il controllo della macchina. L’espediente utilizzato sta nell’improvvisazione prog-jazz: pizzichi, graffi, groove frastagliato, accordi d’organo stridenti, stop & start.
Su “Not Waving” cambiamo invece paesaggio e trama: è una canzone sulla dissoluzione, o meglio sull’annegamento. Il tema è preso dalla poesia di Stevie Smith, pubblicata nel 1957, “Not Waving but Drowning”. Il trombone chiama l’aldilà, i droni d’oltretomba rispondono.
Con “Twilight Furniture” si insiste nel vocalizzo tormentato, questa volta a sfondo politico, senza mai districare l’intreccio ordito in partenza, tra uomo e macchina: “Occhio chiuso, occhio di metallo”. L’accompagnamento è prevalentemente percussivo.
“24 Track Loop” ha quella marcatura industriale di cui s’accennava all’inizio: fanfare metalliche sotto il ritmo del charleston, arricchito da suoni robotici e inquieti. Un pezzo “da 90”, non ortodosso, che suona più come un ritaglio di musica dance dei primi anni ’70.
“Diet Of Worms” è la più tosta del lotto. Essa costituisce la prova che si tratta di composizioni senza età. Eppure qualcosa potrebbe non tornare a un orecchio più attento. Com’era possibile che in un clima punk (rectius post-punk, e già abbiamo visto come il passaggio fosse stato rapidissimo) questa band potesse avere un pubblico? La risposta sta nelle correnti sociali che s’agitavano a quel tempo, anzi è lo stesso Hayward a confessare da cosa nascesse il loro piccolo successo: “Dal desiderio di commettere violenza su nozioni musicali accettate.”
E se tutto allora debba nascere da un capriccio, “Rainforest” ne è l’esatta rappresentazione. Trama discontinua, tesa a fondersi con “The Fall of Saigon”, perfetta sintesi del periodo storico, tra gong, clangori e voce onirica.
È un nuovo “Apocalypse Now”.
Abbordabile l’edizione These Records del 1991, con ottimo dr medio pari a 11.
 White Heaven – Out (PSF, 1991)
White Heaven – Out (PSF, 1991)Chi ha vissuto l’alba degli anni ’90 può, a conti fatti, definirsi un privilegiato. La scena musicale underground brulicava di sorprese. Era una fucina d’infaticabile produzione, ma al tempo stesso elitaria.
Stavolta approdiamo a Tokyo, Giappone. Non credo che all’occidente, prima di quell’anno, fosse mai interessato il rock che si producesse laggiù. In fondo, altro non poteva essere che un rock derivativo. Diciamo subito che la questione intorno l’origine di questo o quell’altro è tediosa e lascia il tempo che trova, tuttavia c’è da fare una precisazione. Se siete convinti che “Nevermind” dei Nirvana fosse stato la grande rivelazione del 1991, allora potreste risentirvi di ciò che leggerete da qui in avanti.
La PSF Records di Tokyo stampò la prima edizione di “Out” in 500 copie. Se siete possessori di una di queste, potreste attirare l’invidia di molti. Questi LP first press sono il Santo Graal d’ogni Indiana Jones della psichedelia. La chimica è esplosiva e nasce, come di norma avviene, dal genio, dall’invettiva di chi ha passato la vita ad ascoltare “quelle” note, suonate in “quel” modo. You Ishihara e Michio Kurihara hanno dato vita a un’atmosfera ombrosa e opaca, dannatamente hard psych, fumante neo-garage. La forma è libera: sa essere pungente quanto uno spaghetti western, virtuosa, e… “strana” al pari di un assolo di Robert Quine. Le influenze sono riconosciute e riconoscibili: John Cipollina, Leigh Stephens dei Blue Cheer, con un approccio in aggiunta di certo simile a quello di Blackmore su “Made in Japan”. Parliamo di ragazzi che amavano letteralmente, durante le prime esibizioni, suonare cover, come ad esempio quella di “Interstellar Overdrive” dei Pink Floyd. Eppure il loro suono, già verso la fine del 1985, stava uscendo fuori. Il gruppo è stato fondato esattamente nel 1980 da You Ishihara (voce e chitarra). I membri in prima battuta erano tanti, andavano e venivano. Si trattava in sostanza di una serie di jam session tra l’avanguardia e il “noise” di quegli anni. La versione originaria di “Out” è stata pubblicata nel 1989, su cassetta, ma parliamo di un album quasi del tutto diverso da quello definitivo del 1991. Com’è possibile che passò così tanto tempo dalla formazione della band alla prima pubblicazione ufficiale? La risposta è stata data dallo stesso Ishihara: “Uno dei motivi era che avevamo avuto così tanti cambi di personale… ma il motivo principale era che nessuna casa discografica a Tokyo era interessata a pubblicare la nostra musica e non avevamo i soldi per pubblicarla noi stessi.”
Su “Out” abbiamo sei tracce e ciascuna a modo suo rappresenta una bestia misteriosa. La connessione con loro avviene tramite riverberi e distorsioni, che generano una sorta di “risonanza” in grado di lasciarti imbambolato per tutta la durata dell’album. Ai bordi, se ci concentrassimo in un immaginario décadrage fotografico, troveremmo paranoie multidimensionali, tenute insieme da un rumore ambientale di fondo.
In parte è cinema.
Imperdibile, a questo punto, diviene la recente ristampa in vinile Black Editions, definitiva, che va a migliorare il precedente dr medio pari a 9 dell’edizione Psf.

 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì
 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì


 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì

 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì



 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì




 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì
 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì

 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì

 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì





 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì
 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì




 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì
 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì




 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì


 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì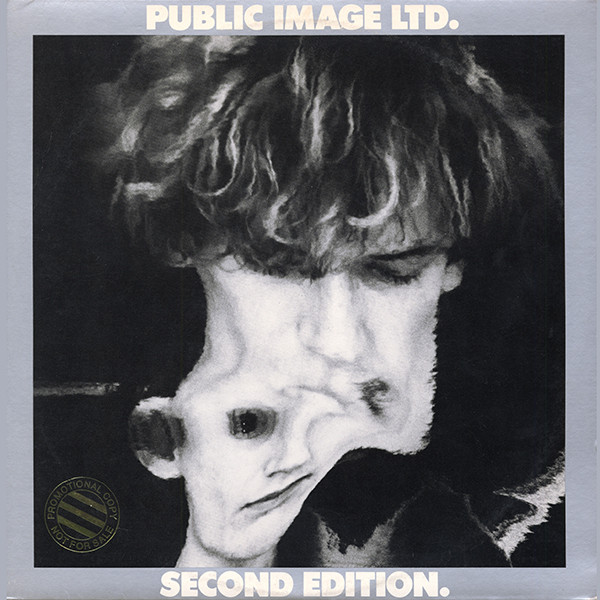


 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì
 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì
 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì

 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì
 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì
 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì



 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì
 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì




 Re: Ogni maledetto venerdì
Re: Ogni maledetto venerdì